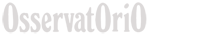NATURA E CULTURA 6
Le masserie fortificate
Il territorio rurale fasanese è fortemente innervato di masserie,

termine derivante da massae o massaricius, con cui si indicano estensioni di terreno poste in proprietà privata, dotate di costruzioni (residenze padronali e coloniche, ovili, frantoi, cantine, depositi per gli attrezzi e altro ancora) attraverso le quali si svolgono e si orientano i cicli di produzione e di organizzazione del lavoro agricolo e delle attività legate alla pastorizia o all'allevamento di bestiame di vario genere. Sebbene una simile struttura produttiva abbia avuto delle specie di “antenati” in epoca preclassica, romana (si pensi alle tipiche villae) o feudale (l'economia curtense), tuttavia è soprattutto a partire dal XIV-XV secolo che le masserie prendono a diffondersi, caratterizzando il paesaggio agrario locale. Spesso esse sorgono in stretta contiguità cronologica e al di sopra (sub divo) dei centri di agricoltura più antichi, costituiti dai villaggi rupestri dell'alto e del basso Medioevo, mentre talvolta testimoniano della presenza di grancie o possedimenti dei monasteri benedettini di Fasano, Monopoli o anche di cenobi manastici più lontani, quale poteva essere ad esempio quello di San Nicola in Casole, vicino Lecce. Ogni masseria è da intendersi come un florido centro di coltivazione e allevamento perfettamente autosufficiente, frequentemente costruito con modalità architettoniche utili a respingere gli attacchi saraceni (e no) provenienti dal mare, e ad evitare le razzìe collegate al fenomeno del brigantaggio, diffusissimo fra il Cinquecento e l'Ottocento. Ed ecco quindi comparire sovente gli elementi necessari alla difesa dagli attacchi esterni, con gli alti muri di cinta interrotti solo dal portale, i torrioni angolari, il camminamento lungo il parapetto di coronamento, le scale a pioli interne o ricavate nello spessore della muratura, i ponti levatoi insieme alle garitte, alle feritoie e alle caditoie in corrispondenza delle aperture, in un corredo di soluzioni edilizie mutuato essenzialmente dai veri e propri castelli medievali. In un'unità composita, pertanto, vengono ad essere coordinati gli aspetti residenziali, lavorativi, religiosi e associativi della vita di campagna: gran parte delle masserie possiede fra l'altro la tradizionale e preziosa cappella, la chiesetta dove i proprietari e il contado potevano (e in alcuni casi possono ancor oggi) celebrare il rito cristiano. Sotto il profilo prettamente architettonico, non di rado sono rilevabili rimaneggiamenti e aggiunte progressive di ulteriori corpi di fabbrica agli ambienti originari, costruiti in base alle esigenze che di volta in volta si presentavano nello svolgimento delle mansioni agricolo-pastorali.
L'itinerario consigliato. Basta avventurarsi un po' ovunque nelle campagne dei dintorni di Fasano, per imbattersi in qualche magnifico esempio di masseria, fortificata o meno che sia. Sulla provinciale che unisce Monopoli a Torre Canne, a circa 3 chilometri da Savelletri in direzione sud, si imbocca sulla destra un tratturo che conduce alla splendida Pettolecchia, svettante nella bellezza delle sue forme all'interno di un muro di recinzione. Il corpo principale è composto da una sorta di parallelepipedo centrale, rinforzato agli angoli da quattro torrioni con alto basamento a scarpa segnato da un cordolo litico, che conferiscono all'edificio l'aspetto di un castello. Un piccolo fossato, oggi interrato, circondava le ripide pareti della masseria, che era dotata anche di un ponte levatoio (sostituito attualmente da un'arcata) che interrompeva il passaggio dalla scalinata alla entrata principale. Sul portone d'ingresso, al primo piano, sono visibili un'epigrafe e lo stemma nobiliare, sormontati da una caditoia di dimensioni maggiori rispetto alle altre laterali, e da un campanile a vela. Un parapetto di coronamento, all'altezza del terrazzo, protegge un camminamento segreto. Staccata dal “castello” è la chiesa, risalente al XVIII secolo, munita di un rosone centrale e coperta da una cupola con lucernaio. Ugualmente a parte sono i locali di deposito e le vecchie stalle, e il precedente insediamento rupestre, riadattato in un primo momento a trappeto e poi a penitenziario, con celle ricavate lungo il perimetro della grotta. Il nucleo primigenio di Pettolecchia risale al XVI secolo, epoca di continui assalti turchi dal mare, che resero opportuno un allineamento di masserie fortificate lungo una linea posta immediatamente a ridosso della costa. Già di proprietà della famiglia Palmieri di Monopoli, nel 1962 Pettolecchia è stata ceduta all'Ordine dei Gesuiti, con i relativi uliveti che la circondano.
Tornando sulla litoranea, procedendo in direzione Capitolo, si incontra facilmente la segnaletica di svolta a sinistra per accedere alla masseria San Domenico, uno dei luoghi più chic per il turismo in zona. Nelle strutture del XVIII secolo, infatti, è stato creato un complesso residenziale a cinque stelle, che non ha intaccato le antiche forme architettoniche. Il nucleo storico della masseria risalirebbe al '400, quando qui sorgeva una semplice torre d'avvistamento dei Cavalieri di Malta, ampliata nel '700 con ulteriori aggiunte strutturali. Nella odierna definizione architettonica, dentro un recinto con ingresso ad arco, si eleva un edificio turriforme a tre livelli, con il coronamento superiore e le classiche caditoie disposte su ogni lato, e con un campanile a vela sagomato. La scalinata esterna a doppia rampa conduce ai piani alti della residenza padronale, scanditi da lesene di corniciatura, mentre al pian terreno sono distribuiti i locali dove un tempo avveniva la stagionatura dei formaggi e il ricovero degli attrezzi, e dove c'era il forno, in vani coperti da volte a stella. Anche a San Domenico esisteva un insediamento rupestre, mutato successivamente in frantoio, in un settore poco distante dalla “torre”. Accanto, vi è ora un'azzurrissima piscina realizzata sempre “in rupe”, con contorno di immancabili alberi d'ulivo e prato. I corpi di fabbrica che corredavano l'edificio primario sono stati reinterpretati come vani per l'accoglienza dei soggiornanti d'élite.
Proseguendo l'itinerario da Savelletri a Fasano, in contrada Coccaro si incontra la settecentesca masseria Maccarone, di proprietà Colucci. Il complesso rurale comprende la residenza padronale a due piani (con tracce di stile barocco), l'alloggio per il massaro, i depositi (dove è stato realizzato un museo dell'antica civiltà contadina con circa 1.200 attrezzi in uso nell'azienda dal 1700 ad oggi), il frantoio (ricavato in grotte basiliane del 1200), il forno e una bella cappella, decorata in facciata da un coronamento a semicerchio e da una finestrella a losanga, collocata sopra l'architrave a timpano che orla l'ingresso. All'interno dell'edificio cultuale, l'ambiente rettangolare è caratterizzato da volta a botte e a vela al centro, con l'altare frontale decorato da un paliotto su cui è scolpito un cartiglio con elementi a volute e il cuore trafitto della Vergine. Alle spalle del presbiterio è sistemata una tela con la Madonna delle Grazie e Santi, cui è sovrapposto un fastigio scultoreo con il monogramma della Vergine, sul quale poggia una corona regale in pietra e la formella con la data del 1758. Su un paio di mensole laterali risaltano le figure in pietra scolpita e colorata di Sant'Antonio da Padova e dell'Addolorata. Interessante l'acquasantiera che raffigura in rilievo il Battesimo di Cristo, unitamente al matroneo, cui si accede da una scala ricavata nello spessore del muro.
Da Fasano, prendendo via San Lorenzo, si arriva ad una fra le masserie più affascinanti dell'intero comprensorio: si tratta di Sant'Angelo de' Graecis, meglio conosciuta proprio come San Lorenzo, dalla dedicazione dell'annessa chiesetta, in cui si perpetua la devozione per il santo attestata in età medievale nel vicino insediamento rupestre. La masseria, il cui nucleo primigenio risale al XII secolo d.C., quando qui c'era una grancia del monastero basiliano di San Nicola in Casole (presso Otranto), è agevolmente riconoscibile anche a notevole distanza per l'imponenza della torre merlata che campeggia sulla sinistra dell'edificio residenziale. Nel XIII secolo d.C. la proprietà dovette passare nelle mani dei benedettini del monastero monopolitano di S. Stefano, prima di divenire nel XIV secolo una badia concistoriale, vale a dire una rendita cardinalizia. Alle spalle del palazzo padronale, suddiviso in piano-terra e piano-alto e costruito con blocchi di “carparo” (il tufo delle Murge) dal tipico colore giallognolo in leggero “bugnato”, si trova un giardino apparecchiato elegantemente ad agrumeto, al quale si accede attraverso una grande porta ad arco, in cui l'arte del ferro battuto si mescola con ricercate soluzioni di ornamento architettonico. L'abitazione colonica, invece, è collocata sulla destra del prospetto di facciata della masseria, nel classico candore conferito alle pareti dalla mano di calce che ogni primavera viene passata sui muri: è questa la parte cinquecentesca di Sant'Angelo de' Graecis, la più antica fra quelle attualmente esistenti, con un cortile interno utilizzato come deposito e ricovero per attrezzi e animali. Di fronte alla casa del massaro, spicca l'edificio di un bianchissimo trappeto settecentesco, recentemente restaurato e adibito a Museo dell'Olio d'Oliva: entrandovi si possono ammirare, fra i tanti strumenti di lavorazione olivicola, la grande macina, le piscine per depositare il frutto della spremitura, i fiscoli, i frangisansa e soprattutto dei giganteschi torchi lignei posti sui fianchi del corridoio centrale, appositamente realizzato con un sistema ad archi che garantisce l'omogeneità del gioco di spinte e controspinte verso il soffitto e il pavimento. Ma forse, pur fra le innumerevoli bellezze di architettura e paesaggio della masseria, il “pezzo pregiato” di Sant'Angelo de' Graecis è la cappella, certamente la più maestosa fra quelle rurali del comprensorio: fu eretta a spese del cardinale Giuseppe Renato Imperiale nel 1693, su progetto dell'architetto Biagio Padua di Avetrana, come ricordano le lapidi murate sul fianco esterno destro della costruzione, e si presenta con una facciata parzialmente nascosta dal torrione di fine '800-inizi '900, che le fu addossato per questioni statiche; sul davanti si riconoscono, comunque, delle piatte lesene coronate da una trabeazione a metope e triglifi, sulla quale sporge un cornicione modanato. Alla porta d'accesso dell'ordine inferiore corrisponde la finestra a cornice mistilinea dell'ordine superiore, mentre sul parapetto del terrazzo si notano un campanile a vela e la statua in pietra di un santo. Internamente, la chiesa conserva ancora il battuto originario in ciottoli e tufina pressata, ed è planimetricamente congegnata a mo' di aula lunga e rettangolare, coperta da una eccezionale volta a botte unghiata sulle finestre laterali. Un cornicione modanato e aggettante, che sormonta sempre metope e triglifi, definisce il perimetro interno della struttura, marcando l'imposta della copertura. In alcuni dei sei nicchioni che simmetricamente si dispongono sui lati lunghi dell'edificio sono conservate alcune tele di scuola romano-campana: si riconosce un S. Francesco che riceve le stimmate (XVII secolo), la Madonna della Madia (XVII secolo), e un S. Lorenzo martire (XVII-XVIII secolo), con dipinti inseriti in altari lignei e policromi di scuola baroccheggiante, la cui sezione anteriore è stata sostituita negli anni Venti del Novecento da avancorpi in marmo locale. Il presbiterio è invece ornato dall'immagine di S. Michele Arcangelo che trafigge il drago (o demonio), opera di un anonimo pittore attivo in ambito locale e aperto alle esperienze compositive proprie dell'ambiente napoletano (XVIII secolo). Una porticina laterale consente un secondo accesso sulla destra dell'edificio, restaurato nel 1878 e nel 1982. La masseria di Sant'Angelo de' Graecis è di proprietà della famiglia Colucci-Amati dal 1798, e ospita sovente convegni, cerimonie nuziali al chiuso e all'aperto, concerti di musica classica e jazz, in un contesto storico-architettonico davvero speciale.
Riprendendo via San Lorenzo, si perviene dopo un paio di chilometri al cavalcavia, attraversato il quale è possibile scorgere la masseria fortificata di San Marco, sorta in posizione contigua e parzialmente sovrapposta all'insediamento rupestre (cfr. apposito capitolo di questa guida, n.d.r.) che le dà il nome. Appena intercettato con lo sguardo il complesso architettonico, ci si rende immediatamente conto di trovarsi di fronte a un autentico gioiello. Corredato da caditoie e mura di cinta impreziosite agli angoli da garitte circolari dal vago sapore orientaleggiante, il nucleo della struttura risale al XV secolo ed è articolato internamente in uno spiazzo attraverso cui si accede alla scalinata degli appartamenti familiari. Le stalle sono al piano terra, insieme ai magazzini e agli ambienti di servizio. La chiesetta della masseria San Marco possiede anteposta una balaustra in tufo con cancelletto centrale, che precede una facciata inserita in paraste angolari aggettanti e apicate da pinnacoli a forma di globo allungato. La fronte è sormontata da un timpano triangolare, definito da una cornice modanata, mentre sopra al portale è sistemato un oculo ovoidale con piatta corniciatura. L'architrave, a sua volta, presenta sulle estremità l'ornamento “a campanelle”. All'interno, l'edificio religioso è diviso nel settore riservato ai fedeli e in quello presbiteriale. Il primo presenta quattro pilastri che sorreggono i pennacchi su cui è impostata la cupola, splendidamente affrescata nel 1815 da Settimio Carella di Martina Franca, che ha lasciato la firma sull'oculo della controfacciata: agli angoli d'impostazione della copertura emisferica si riconoscono soprattutto le raffigurazioni dei quattro evangelisti (San Matteo con l'angelo, San Marco con il leone, San Luca con il toro e San Giovanni con l'aquila) dipinti nella consueta iconografia e coi relativi attributi. Il presbiterio, balaustrato ed elevato su due gradini, ha una volta a botte unghiata sulle due finestre laterali ad oculi, decorata con pitture a carattere vegetale e figurativo, con al centro il triangolo divino. L'altare litico è in stile neoclassico, con il piano-mensa poggiante su pilastrini a sezione quadrata, seguito da tre ripiani degradanti verso la parete di fondo, impreziosita da due coppie di colonne dal capitello semplice, che mantengono architrave e cornici con pinnacoli apicali, a centrare il fastigio scultoreo. In una nicchietta laterale è posto un curioso lavabo litico scolpito a maschera di fauno (prima metà del XIX secolo), presumibile erede di culti rurali di tipo pagano, “convertiti” a una funzione liturgica cristiana. Anche San Marco è di proprietà della famiglia Amati ed è stata recentemente ristrutturata e adibita a struttura agrituristica.
Una tipica masseria a torre è quella di Ottava Grande, databile al XVI secolo, ed edificata presso la chiesa dell'antico casale del XII secolo d.C. (cfr. capitolo sugli insediamenti rupestri, n.d.r.). Vi si arriva incamminandosi sulla s.s. 16 che va da Fasano verso la frazione di Speziale, e deviando a sinistra sulla bretella che porta alla s.s. 379. Ed ecco spiccare, proprio sul ciglio della carreggiata, l'edificio turriforme, che conserva intatta la sua struttura fortificata con caditoie sulle finestre e scalinata esterna per l'accesso al primo piano. Casa padronale e attigui fabbricati con funzione agricola e domestica sono racchiusi nel recinto murario con arco d'ingresso.
Un simile esemplare architettonico è ravvisabile nella masseria Lamacupa (XVIII secolo), che si raggiunge mediante il raccordo s.s. 379-Pezze di Greco e deviando a sinistra in una strada campestre. Anche in questo caso viene esaltato l'aspetto della torre sviluppata su due piani, con in basso l'abitazione colonica e i depositi, ed in alto la residenza del proprietario. Alle caditoie su finestra è unita la frangia continua del parapetto con beccatelli e lunette decorate. Altri corpi di fabbrica si sono addossati al principale nel corso degli anni, per fungere da locali funzionali alle attività agricole e pastorali. La cappelletta è staccata e collocata fuori dal recinto: ha in facciata un bel timpano spezzato sul portale d'ingresso, cui seguono un oculo con cornice sagomata e il campanile a vela del terrazzo. L'interno è voltato a stella, con il presbiterio sopraelevato di un gradino ad occupare metà dello spazio. L'altare, su due gradini, possiede una decorazione parietale con mensole a reggere due lesene concluse dall'architrave classico, per incorniciare una tela raffigurante la Madonna della Madia. Sui muri laterali sono alcune finestre ad arcosolio e nicchie con cornici aggettanti, che conferiscono un certo movimento alla struttura.
Nei dintorni di Lamacupa si incontrano ulteriori complessi rurali. Lungo l'arteria che congiunge Pezze di Greco a Torre Canne è infatti collocata la masseria Torre Spaccata, osservabile dalla strada nella sua squisita fattura che sottolinea con colori vivaci le peculiarità architettoniche di una aristocratica dimora di campagna, dotata di garitte circolari ai vertici del fabbricato residenziale.
Riadattata recentemente a discoteca è invece Eccellenza, alla quale si perviene dalla contrada Pezze di Monsignore, lungo una via che è la parallela verso l'entroterra della Fasano-Ostuni. Tale masseria settecentesca presenta una spettacolare scalinata a due rampe con balaustra e loggiato. Il coronamento dell'edificio signorile è munito di feritoie, mentre il più recente corpo attiguo alterna spazi destinati ad attività agricole e cortili chiusi su cui affacciano altri vani.
Restaurata è anche la masseria Notarangelo, che si raggiunge dalla vecchia strada per Laureto, deviando al primo bivio a sinistra in contrada Gravinella. Il complesso è databile al XVIII secolo nelle parti più antiche, ed è il risultato dell'integrazione e della aggiunta progressiva e armoniosa di vari ambienti. La cappella è sulla sinistra della residenza, e offre al visitatore una facciata con ingresso sormontato da un timpano in cui si inserisce un oculo con lo stemma gentilizio, scolpito in pietra a disegnare un albero con angeli eretti ai lati. Nella chiesetta, munita di volta a stella, l'altare è corredato da una statua in tufo policromo della Madonna con Bambino, affiancata dai simulacri in pietra di Sant'Antonio da Padova e di San Domenico (XVIII secolo), scolpiti da artisti locali.
Percorrendo la strada che porta alla frazione di Pezze di Greco, e deviando a destra dopo circa 3 km da Fasano (vi è adeguata segnaletica), si arriva alla masseria Salamina, sorta da un originario nucleo fortificato del '600 trasformato poi nel secolo scorso in elegante residenza di campagna. In questa ristrutturazione le caratteristiche precipue della fortificazione si sono un po' perdute, anche se ne sopravvivono alcuni resti nel cortile interno. La facciata principale presenta merlature sostenute da una serie di beccatelli. Al centro spicca una torre anch'essa merlata (forse derivante da una precedente torre fortificata) sulla quale si apre una bella finestra a bifora che sovrasta lo stemma nobiliare della famiglia che commissionò le trasformazioni. Le altre finestre di Salamina sono sormontate da timpani semicircolari. Inoltre sulla facciata principale è stato ricavato un portico coronato da una balaustra di colonnette in pietra. A destra del portico c'è una nicchia con copertura a tetto sostenuta da due pilastrini circolari, in cui è allocata una statua in pietra dell'Immacolata Concezione incoronata. Notevole è poi la vera da pozzo su base esagonale (forse settecentesca) che si trova nel cortile.
Sulla s.s. 16 in direzione Monopoli, quasi al limitare del territorio comunale fasanese, e subito dopo una stazione di servizio, si imbocca una stradina sulla destra che conduce dopo poche decine di metri alla masseria Seppannibale Grande, quella che dà il nome all'omonimo tempietto longobardo (v. capitolo sugli insediamenti rupestri, n.d.r.). Non è solo tale pregevolissimo monumento, però, a dar lustro a questa masseria fortificata, così chiamata perché appartenuta a un certo Giuseppe Annibale Indelli (oggi proprietà Calefati). Il corpo di fabbrica principale è a due piani con struttura a torre, dotata dei classici elementi di difesa (caditoie). Da una lunga scalinata esterna si accede al primo piano. Nelle sale della dimora “padronale” si possono ammirare sulle volte e sulle pareti dei curiosi affreschi tardo-settecenteschi che rappresentano vedute di campagna e città, con passanti, animali, contadini al lavoro e scene di donne al bagno. Questi soggetti femminili, naturalmente, erano stati dipinti dall'ignoto artista nudi o seminudi. Ma chi poi abitò nella masseria volle far coprire quelle nudità con una mano di vernice scura, e così “censurati” gli affreschi si presentano oggi all'osservatore. I paesaggi, sia pure in maniera meno raffinata, richiamano alla mente i giardini dipinti dai Carella nella vicina Martina Franca. Staccata dall'edificio centrale, si erge la cappella secentesca di pertinenza del complesso rurale, con ingresso odierno dalla corte sul fianco laterale. Il prospetto della chiesetta presenta un coronamento mistilineo, un campanile a vela centrale con due pinnacoli antropomorfi simili a quelli che adornano il timpano sul portale, due finestre rettangolari, un'apertura circolare occultata. La pianta interna è rettangolare, con presbiterio rialzato, volta a botte, lunette marcate da una cornice in rilievo, affresco raffigurante la Madonna del Carmine tra le anime purganti inserito fra due aperture simmetriche.
Al termine di questo itinerario, da non perdere è la fortificata masseria Coccaro, nella contrada omonima, a nord-est di Fasano, verso Savelletri (oggi trasformata in lussuoso relais). Databile al XVII secolo, comprende la torre con pochi locali usati per deposito, all'interno di un giro di mura interrotte dall'ingresso ad arco con caditoia centrale, contornata da un rilievo della Vergine con Bambino e una croce in pietra. Di fronte alla costruzione padronale è la deliziosa chiesetta (XVII-XVIII sec.), dedicata al Crocifisso. Essa ha una facciata rettangolare con portale a paraste e timpano, sormontato da una finestra con profilo mistilineo. Nel settore superiore, che termina a triangolo, è sistemata una lunetta in cui appare un bassorilievo del Cristo deposto, opera di uno scultore locale sensibile all'influsso della grande scultura d'epoca rinascimentale, che privilegia proprio quel motivo sacro. Internamente la piccola ecclesia ha un soffitto a crociera con la chiave di volta costituita da un rosone. L'altare è in pietra tenera e policroma, col piano-mensa sostenuto da pilastrini a volute. Ai canonici ripiani succede una nicchia incorniciata da foglie e rosette, in cui è l'immagine del Calvario, oltre ad una croce in legno col Cristo in cartapesta. Interessante è la doppia fontana-lavabo, con la vasca inferiore rilevata a motivi fitomorfi e bordo modanato, e quella superiore scolpita a maschera di satiro fra valve di conchiglia, putti ed elementi vegetali.
Nelle masserie del fasanese, insomma, c'è tutto quanto la micro e macro-storia quotidiana possa raccontare: il faticoso lavoro giornaliero, l'angoscia del doversi difendere dagli “infedeli” musulmani o dai briganti, la profonda religiosità del mondo rurale che ammicca qua e là a reminiscenze pagane, il senso dell'arte e delle forme architettoniche, il rispetto per la natura. Un concentrato di vita, dunque, che sprizza fuori da una terra colma di frutti e benedetta da Dio, in cui si sono avvicendati uomini e famiglie, ringraziamenti e maledizioni, sudore e sangue.
di Redazione
25/03/2012 alle 00:00:00
altri articoli
Leggi anche:
OsservatorioOggi
laboratorio urbano
Natura e cultura 1
Natura e cultura 2